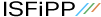
ISFiPP punto di incontro tra
Filosofia, Psicologia e Psichiatria
ISFiPP
Corso Fiume 16,
Torino,
ITALIA,
10133
011 660 6126
segreteria@isfipp.org
Dasein Journal
Rivista di Filosofia e Psicoterapia Esistenziale
OnlineFirst
Il Medico e la Morte
- 2021
- DASEIN 9
«Ma, evidentemente, l’essere umano continua ad essere mortale: se da un lato quindi il medico non si arrende e, ripetiamolo, non deve arrendersi (in modo che nuove ricerche aprano nuove frontiere per il bene dell’essere umano), dall’altro il medico deve saper intrecciare in se stesso questa matrice di non arrendevolezza con l’evidenza della inevitabilità della morte.»
Abstract
La formazione culturale, tecnica e scientifica del medico difficilmente offre spazio di riflessione relativamente alla morte. Tuttavia, a meno di non cadere in un circuito di rimozione, Vita e Morte, Cura e Malattia si intrecciano ed inevitabilmente mettono alla prova il medico. Può la preparazione tecnica, da sola, costituire un sufficiente equipaggiamento per il medico di fronte ai limiti “estremi” dell’esistere? Si può fare a meno di discipline come la psicologia e, forse soprattutto in questo caso, come la filosofia?
Parole chiave
Diversi sono i livelli ai quali il medico fa esperienza della morte. La morte è, innanzitutto, un “fatto”, sancito e definito in termini di medicina legale in modo che il medico sia in grado di definirne l’accadimento, di rilevarne la fenomenologia, di costruire l’adatta e necessaria documentazione ad essa inerente.
Come ovvio, però, un altro livello al quale il medico è chiamato a far incontro ed esperienza con la morte è di natura esistenziale: la morte di una paziente o di un paziente costituisce un evento che vede l’essere umano a contatto con quanto di più “al limite”, di più definitivo, di più potenzialmente doloroso possa accadere nella sua esistenza.
La formazione scientifica, culturale, esperienziale, tecnica del medico offre occasioni di apprendimento anche molto sofisticate che però, generalmente, almeno secondo il parere di chi scrive, spesso tralasciano ampiamente i temi della morte e della perdita nella loro dimensione filosofica, da un lato, e psicologica dall’altro, in un certo senso lasciando il medico “solo”, cioè senza il supporto di pensieri coordinati, di riflessioni organizzate, di inviti a guardare alla morte quale evento inevitabile ma anche capace di suscitare emozioni, pensieri, comportamenti, modalità comunicative, atteggiamenti che vanno poi a connotare e costruire parte dell’attività del medico stesso (basti pensare agli aspetti comunicativi col paziente, laddove la comunicazione sia ancora possibile, e/o con i suoi congiunti a fronte di un inevitabile exitus).
Una maggiore attenzione per questi temi nell’ambito della formazione, universitaria o post-universitaria che sia, potrebbe supportare l’attività del medico nella sua pratica quotidiana migliorandone gli aspetti comunicativi e relazionali con il paziente morente, con i suoi familiari o, più in generale, con i suoi affetti più vicini? Chi scrive ritiene di sì ed in questo breve lavoro proveremo ad offrire una testimonianza di come tutto ciò possa prendere forma in una esperienza concreta di accompagnamento alla morte, attivamente partecipata dal medico, all’interno di una cornice interpersonale di consenso e di accordo col paziente stesso e con i suoi familiari.
Ci servirà una porta di ingresso, come un passaggio che ci introduca in un luogo in cui la relazione tra il medico ed il suo paziente ha saputo rappresentare, oltre che il necessario terreno di scambio per meglio comprendere gli aspetti diagnostici ed i conseguenti espedienti terapeutici, il momento di una alleanza non solo terapeutica ma più estesamente esistenziale, capace di provvedere al tentativo di facilitare il passaggio verso il momento conclusivo della vita biologica come tutti noi la conosciamo, momento inevitabilmente legato a maggiori o minori tensioni emotive, paure, disorientamenti.
Un primo elemento di riflessione, a costituire questa porta d’ingresso, vuole essere la semplice ma al contempo profonda considerazione della matrice spazio-temporale dell’esistenza dell’essere umano. Noi siamo impastati di spazio e di tempo, i nostri corpi si trasformano nei giorni e negli anni, le nostre relazioni non sono statiche ma, almeno entro certi limiti, vedono accadere cambiamenti, evoluzioni, accadimenti che ne modificano aspetti logistici ed esterni ed aspetti di rappresentazione interna; allo stesso modo cambiano i nostri pensieri e le nostre convinzioni, che spesso arrivano a differenziarsi lungo gli anni, ad esempio dagli anni della nostra gioventù a quelli della fase più matura della nostra vita, e così via.
Il più delle volte si tratta di una dinamicità che, pur prevedendo “un prima ed un dopo”, pur sempre appare almeno in parte reversibile o, comunque, capace di aprirsi ad esperienze e novità in un qualche modo simili a quanto ha fatto parte di ciò che viene oltrepassato: ad esempio, una relazione significativa può evolvere in una separazione, ma questo non significa che i soggetti in gioco non potranno continuare una vita di relazione, né si può escludere che la stessa separazione non sia il passaggio verso un nuovo modo di relazionarsi tra gli stessi protagonisti. Si tratta, in altri termini, di trasformazioni lungo le dimensioni dello spazio del tempo assai significative ma che, almeno potenzialmente, non precludono una prosecuzione dell’esperienza nel e del mondo. Con la morte tutto ciò acquista una prospettiva radicalmente e totalmente diversa. Certo non solo la cessazione della vita biologica si dà come evento capace di influenzare il vissuto di progetto nel mondo: sappiamo, infatti, quanto eventi esistenziali particolarmente importanti possano andare a costituire un trauma psichico e quanto questo possa, nei casi più drammatici, significare un’interruzione più o meno completa dello spazio e del tempo vissuti. Tuttavia, il soggetto traumatizzato potrebbe non aver perduto completamente la propria capacità progettuale e la potenzialità di incontrare nuovamente il vissuto del mondo, dello spazio e del tempo, con l’esperienza psicoterapeutica che, dunque, si dona come espediente curativo capace di promuovere il tentativo di tale recupero. Con la morte, invece, il tema del “prima e del dopo” si radicalizza: la morte porta con sé il termine del tempo senza possibilità di reversibilità, un termine che non prevede in alcun modo un qualche tipo di recupero; allo stesso modo per lo spazio, il cui vissuto per il soggetto viene meno e il cadavere, totalmente fermo, occupa ancora uno spazio ma solo fin tanto che i processi di decomposizione non saranno terminati.
Peraltro, a costituire il trauma sappiamo, dalla clinica, essere spesso l’esperienza della morte di una persona significativa, tema, questo, che sottolinea e ribadisce quanto stiamo illustrando.
Più ancora che la psicologia, però, è la letteratura che ci aiuta a comprendere fino in fondo l’impatto emotivo del contatto con questo limite fondamentale: le descrizioni rinvenibili nella letteratura ci danno la misura del vissuto meglio di quanto non riescano i trattati di psicopatologia e di psicologia. Così, Luciano Manicardi nel suo bellissimo libro Memoria del limite (Manicardi L., Memoria del limite, Vita e Pensiero, 2011) ci ricorda alcune scene letterarie che ci fanno intravvedere il disorientamento radicale, l’impoverimento dell’Io, addirittura il senso di colpa del soggetto nel suo incontro con la morte dell’altro amato.
Ne L’ultimo dei giusti (Schwarz-Bart A., L’ultimo dei giusti, Feltrinelli, 1976.) Golda ed Erni, costretti all’incontro con la morte nel contesto della più totale follia umana del totalitarismo omicida nazista, si lasciano al suono di poche parole, «Ma non ti rivedrò più? Mai più?», che conficcano come un pugnale nel cuore del lettore il disorientamento che la radicalità nuda della morte è capace di provocare, a fortiori nelle condizioni tragiche del campo di concentramento.
Così pure Montaigne (de Montaigne M., Saggi, vol I.), che ci disegna il vissuto simile al senso di colpa allorché elementi vitali si presentino dopo la dipartita dell’amico ma prima che il lutto sia stato superato: «Da quando lo persi non faccio che trascinarmi languente; e perfino i piaceri che mi si offrono, invece di consolarmi, mi raddoppiano il dolore della perdita. Di ogni cosa facevamo a metà; mi sembra di sottrargli la sua parte».
Non sono che esempi, altri se ne potrebbero aggiungere. Ciò che ci interessa sottolineare è che un primo elemento da cui partire è lo squarcio che la morte biologica inserisce nel vissuto umano, necessariamente impastato di spazio e di tempo.
C’è un secondo elemento, come un altro prezzo di quella porta di ingresso che vorremmo provare a disegnare. Tale elemento ha a che fare con il ruolo stesso del medico ed è intrecciato con un aspetto paradossale del suo agire, nel senso di prevedere al contempo la presenza di elementi tra loro contrapposti, escludentesi. Infatti, sappiamo che da un lato il medico è, e deve essere, colei o colui che di fronte alla morte, in tutte le sue forme, sostanzialmente non si arrende. In questo senso, basta pensare a tutti i progressi che nel tempo la medicina è stata capace di offrire ad ognuno di noi: non si tratta di miglioramenti nati, in fondo, dal fatto di non essersi arresi ad uno stato di cose in cui la morte avveniva mediamente in età molto più precoci di quanto non accada ora, a volte in modo molto più traumatico e doloroso prima dell’avvento delle cure palliative, eccetera? Le nuove frontiere della ricerca, dell’ingegneria cellulare, della medicina rigenerativa sembrano, in questo ragionamento, solo l’ultima frontiera di un percorso che tenta costantemente di migliorare le condizioni di vita senza, come dicevamo, cedere all’arrendevolezza a fronte della morte e del morire.
Ma, evidentemente, l’essere umano continua ad essere mortale: se da un lato quindi il medico non si arrende e, ripetiamolo, non deve arrendersi (in modo che nuove ricerche aprano nuove frontiere per il bene dell’essere umano), dall’altro il medico deve saper intrecciare in se stesso questa matrice di non arrendevolezza con l’evidenza della inevitabilità della morte.
Quanto stiamo definendo è un tema delicato perché, come ben ci insegna la psicologia sistemico relazionale, nei paradossi diminuisce lo stato di benessere. Quello che ipotizziamo è che il medico debba imparare come abitare questo paradosso, come saperlo vivere in modo progettuale e possibilmente equilibrato: questo, ci sembra, potrebbe evitare, o almeno ridurre, la probabilità che solo uno dei due aspetti che abbiamo descritto prenda il sopravvento, ad esempio con l’accanimento terapeutico, laddove il medico ecceda nella sua capacità di non arrendersi alla morte e dimentichi quanto essa debba anche essere accettata, o, al contrario, con una eccessiva arrendevolezza che, soprattutto nelle situazioni più difficili dal punto di vista clinico (laddove gli strumenti per alleviare la sofferenza siano ancora troppo poco efficaci nel portare significativi cambiamenti nella storia naturale di una patologia) si può tradurre in una difficoltà per il medico a farsi coinvolgere nella relazione con un malato che allo stato attuale dell’arte non potrà vedere significativi miglioramenti.
Paradosso, dunque: non arrendersi mai e sapere accettare, al contempo.
Un terzo elemento, quasi a poter completare il vano di una porta, lo rintracciamo nel riferimento alla tradizione della psicoterapia esistenziale. Naturalmente, oggetto di questo lavoro non è la psicoterapia nè, altrettanto ovviamente, il medico è sempre anche psicoterapeuta, anzi. Ciò che, però, ci persuade nel fare questa proposta è che insito nel modello della psicoterapia esistenziale è il presupposto che buona parte della dinamica psicologica dell’essere umano, da intendersi proprio come gioco di forze agenti all’interno di un metaforico campo psichico, sia connessa al rapporto tra elementi che, tipicamente, la filosofia e più specificatamente la filosofia dell’esistenza hanno identificato, nel tempo, come cruciali per l’essere umano. Così Irvin Yalom (Yalom I., Psicoterapia Esistenziale, Neri Pozza, 2019) ci propone un sistema esplicativo nel quale morte, libertà, isolamento, assenza di senso vanno a significare eventi e vissuti intorno ai quali l’essere umano si trova a dover cercare un proprio equilibrio, essendo essi elementi che, di fatto, impegnano l’uomo nella sua vicenda nel mondo. Nel panorama della psichiatria italiana questi stessi orizzonti concettuali sono stati proposti da Michele Torre (Torre M., Esistenza e Progetto, Ed. Medico Scientifiche, 1982) e ripresi poi da Lodovico Berra (Berra L., Manuale di Psicoterapia Esistenziale, Libreriauniversitaria.it, 2011) esposti in testi costituenti riferimenti imprescindibili per questo modo di guardare allo psichismo, alla psicopatologia ma, più in generale, all’essere umano in quanto tale: si pensi ad Esistenza e progetto o al Manuale di psicoterapia esistenziale.
Ma in che modo tutto ciò può rientrare in un discorso generale sul rapporto tra il medico e la morte? Vi è un concetto, quello di insufficienza esistenziale, che gli autori suddetti presentano come capace di illustrare, in un certo senso, un insieme di matrici causali del disagio psichico e delle diverse costellazioni psicopatologiche che, nello specifico ed individuale intreccio delle componenti genetiche, psicologiche, ambientali e filosofiche di ogni essere umano, possono prendere vita. Proponiamo che, allargando la prospettiva e così trascendendo lo specifico psicopatologico, gli elementi in gioco nell’insufficienza esistenziale si possano pensare come costitutivi della sufficientemente buona o meno relazione tra l’essere umano e gli accadimenti da lui vissuti ed incontrati. Dunque, si tratta di elementi capaci di descrivere qualità e attributi relazionali che, a ben vedere, possono essere coinvolti nel rapporto tra il medico e l’evento della morte, sulla cui pregnanza e sul cui impatto emotivo abbiamo già ampiamente fatto riferimento.
Sintetizzando, inevitabilmente, il ragionamento delineato attraverso questa prospettiva si possono focalizzare sei punti nodali capaci di descrivere quale dovrebbe essere, idealmente, il modo di porsi più adeguato, nel senso di progettuale, del medico a fronte della morte e del morente. Il medico dovrebbe quindi essere capace di:
- 1) continuare a saper cogliere aspetti positivi del mondo, a cominciare dal“mondo” vissuto in quel momento nella relazione col paziente;
- 2) mantenere il rapporto intersoggettivo valido e vitale con la persona che soffre laperdita;
- 3) saper stare in equilibrio tra gli affetti ed i pensieri connessi alla perdita e allaperdita-limite che la morte costituisce;
- 4) essere sufficientemente sicuro e determinato nel vivere la situazione reale dellaperdita;
- 5) mantenere la capacità di decisione;
- 6) avere sufficiente resistenza e tolleranza alla frustrazione limite imposta dallamorte.
A noi pare evidente quanto ciò che è stato descritto non possa essere pensato checome frutto di un lavoro personale. In gioco ci sono elementi psicologici da unlato, antropologici e filosofici dall’altro.
Inevitabilmente, la formazione del medicodovrebbe, in misura maggiore di quanto non accada ad oggi, prevederne unaconsiderazione e una trattazione tali da favorire la presa di coscienza della loroimportanza nell’agire medico, dal punto di vista relazionale e comunicativo.
Immaginiamo, per un momento, che quanto sin qui detto convinca la lettrice e illettore a proseguire: abbiamo pensato una porta di ingresso, ora attraversiamola.
«C’era un tempo in cui la morte stessa era giovane e virile quando falciava senzascrupoli il genere umano; ora anche la morte è invecchiata, tenuta in disparte, unterrore represso consegnato a qualche soffitta della nostra memoria. Nelcomplesso essa era rapida: si era ben vivi un giorno e belli morti il giorno dopo.Non c’era una grande zona grigia fra la vita e la morte»(Brown G., Una vita senza fine?, Raffaello Cortina Ed. 2014).
Oggi essa ci sbocconcellaun poco alla volta durante il nostro inevitabile declino (Alvarez W., Clinico in Chicago). I concetti di “anziano” edi “vecchiaia” sono datati: ci sono gli anziani di 85 anni, ci sono i grandi anzianifino a 100 anni e poi i centenari oltre i 100. Ma se abbiamo avuto un notevolesuccesso nel rimandare i decessi, abbiamo significativamente fallito nel rimandarel’invecchiamento. Questo ha enormi conseguenze sulla vita sociale, psicologica,economica dell’intera popolazione mondiale. Poche persone infatti ragionano cheil morire un po’ alla volta di vecchiaia, di demenza, di malattie croniche, ha deicosti economico-psicologici personali e sociali spaventosi. In passato la morte ha avuto almeno tre significati fra loro collegati ma distinti. In primo luogo veniva riferita prevalentemente al processo del morire come nella Morte di Ivan IIi’ič. In secondo luogo, indicava l’evento terminale alla fine della vita. Infine denotava uno stato ben definito. Diventare un essere umano completo è un processo complesso; rientriamo crescendo per anni e decenni ma poi ne fuoriusciamo; ciò non significa che l’invecchiamento sia sempre una crescita: al contrario, un centenario non è mentalmente e fisicamente lo stesso di un neonato. Crescere ed invecchiare possono essere pensati come un “entrare” ed un “uscire” dalla vita, pensando alla morte ed alla vita come un concetto analogico. Inoltre il concetto di morte non è più un concetto unitario: c’è una morte a livello molecolare, cellulare, degli organi, dell’individuo, della specie, della cultura, del desiderio. La morte sociale, la morte psicologica, la morte delle nostre capacità fisiche e mentali
(Foot Moore G., Storia delle religioni, ed. CDE su licenza Laterza, 1989).
Al giorno d’oggi c’è il tentativo di trasferire la morte acuta in una morte cronica: curare le malattie non paga perché si perde il paziente, mentre convertire una malattia acuta e cronica rende veramente tanto. Possiamo pensare che la morte di un anziano sia fisiologica mentre la morte acuta e improvvisa di un giovane sia in qualche modo innaturale. Di fatto è vero proprio il contrario. La morte da vecchi è rara fra gli animali selvatici ed era rara fra gli uomini solo un secolo fa. Solamente nelle forzate condizioni della società e della medicina attuali possono fiorire le malattie e le morti esotiche della vecchiaia. Nel corso della storia la gente ha pensato di sfuggire alla morte e cercare l’immortalità in tre modi: spirituale, genetico, culturale. Possiamo sopravvivere come spiriti in qualche vita dell’aldilà; possiamo sopravvivere trapiantando i nostri geni ai nostri figli e ai figli dei nostri figli; possiamo sopravvivere con le opere le azioni e i ricordi lasciati alla nostra famiglia, agli amici o alla società in generale. In molte culture dell’epoca pre-egizia ed egizia stessa almeno tre idee erano presenti: la prima era quella di un dio salvatore che muore e risorge e che può elargire a tutti il tono della immortalità; la seconda era quella di un giudizio dopo la morte in cui la qualità della vita dello scomparso ne avrebbe influenzato il destino finale; la terza, che potrebbe essere molto più antica, era che il novello morto dovesse compiere un viaggio dal mondo dei vivi al mondo sotterraneo. Il concetto di “resurrezione della carne” nasce successivamente nel periodo ellenistico dell’ebraismo fra il IV secolo a.C. e il II secolo a.C. Il profeta Isaia (Isaia,26,19)
(La Bibbia, UTET, 1979), annuncia che «vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri». In base ai loro meriti ad alcuni sarà garantita «la vita eterna altri consegnati alla vergogna e per l’infamia eterna» (Daniele,12,2) (Mistica Ebraica, Einaudi, 1995).
Dunque per il cristianesimo morte, malattie e invecchiamento sono le conseguenze del peccato originale. Secondo l’Islam che in arabo significa sottomissione, Dio determina ogni cosa, Dio prende l’anima delle persone: e il defunto viene presto visitato dall’angelo della morte e deve affrontare una sorta di esame dottrinale della tomba dal cui esito dipenderà il suo futuro verso il paradiso o l’inferno. I buddisti e gli induisti hanno un atteggiamento differente credendo in una rinascita-reincarnazione nello stesso mondo. Alla fine il loro paradiso è perdersi nel nulla o nell’infinito del cosmo. Nel nostro mondo occidentale la storia presenta almeno tre punti di vista: nel Medioevo prevale l’accettazione della morte come parte della vita cioè una transizione come la nascita, il battesimo, il matrimonio e ci si aspettava conducesse alla fine all’eternità in paradiso; come in altre situazioni. Il rituale era semplice: dopo la morte il cadavere veniva affidato alla chiesa in attesa di certa resurrezione al secondo avvento di Cristo; dopo che i corpi erano consumati in fossa temporale, le ossa venivano gettate in ossari comuni (Duby G., L’arte e la società medievale, ed. CDE su licenza Laterza & figli, 1977).
Nel Rinascimento riemerge l’individuo dopo un millennio di collettivismo; ciò rispecchiava il definirsi di un’idea dell’io atomico digitale contro una precedente visione collettiva. Ma con l’avvento del Romanticismo e la scoperta culturale del sentimento la morte venne percepita come una calamità. Il XX secolo ha visto un incredibile capovolgimento dell’atteggiamento verso la morte che è diventata qualcosa di nascosto, di soppresso, anzi un tabù per il quale l’esperienza reale della morte di altre persone o della vista dei cadaveri è stato completamente rimosso. La morte e il morire sono state medicalizzate e professionalizzate. Non appena qualcuno dà segni di morte incipiente viene spedito in ospedale; una volta che si è cadavere il corpo viene maneggiato da professionisti in modo che la famiglia venga in contatto il meno possibile con il defunto. In funzione di ciò, la cultura del trapasso è stata sostituita con il culto della giovinezza. D’altronde le sempre migliori cure mediche e il benessere sociale hanno modificato le prospettive di vita: nel 1800 essa era di trent’anni con un’altissima mortalità infantile; nel 2000 è arrivata oltre i 75 anni e le proiezioni invitano a credere che la vita potrà giungere entro la fine di questo secolo a 120 anni(Musso A., Lezioni sul trapasso, 2014). Con tali prospettive la morte non viene più accettata né a livello emotivo né a livello cognitivo; deve necessariamente esserci una causa, un errore umano, e un nesso causale: non ultima la possibilità di scaricare su terzi le proprie paure e responsabilità intasando spesso forzosamente il sistema giudiziario, considerando che la maggior parte delle cause contro i medici e gli operatori sanitari terminano in un nulla di fatto (oltre il 95% di assoluzioni).
Anche per la burocrazia la causa di morte di un anziano in particolare non può essere semplicemente per vecchiaia ma deve esserci un motivo più o meno valido. Tutto ciò porta all’illusione del controllo a dispetto del fatto che sia coloro che trascurano del tutto la propria salute, sia gli iper-salutisti presentino un tasso di mortalità assolutamente identico (Lindsay Prior - Prior L., The changing face of death, Palmgrave Macmillan, Basinstoke 1997). Per tutti coloro che hanno la fortuna o la sfortuna, a seconda dei punti di vista, di invecchiare c’è una sorta di auto-preparazione all’exitus, vale a dire la progressiva perdita di autonomia funzionale in favore di dipendenze farmacologiche o tecnologiche che trasformano le persone da soggetti in oggetti con la dignità che va a pezzi insieme al corpo; così come quando la nostra mente si deteriora e la perdita di memoria, l’incapacità di formare nuovi ricordi, lo scadimento sensoriale visivo e uditivo e l’aumento dei tempi di risposta del cervello, attenuano parzialmente lo stato di depressione. Ciò malgrado, la psichiatra Elisabetta Kubler Ross (Kübler-Ross E., La morte ed il morire, 1969) ipotizzò che nel morire le persone passino attraverso le cinque fasi: negazione, incredulità, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione. E l’appartenenza a fedi religiose non ne modifica la scaletta. «La vita è piacere, la morte è pace. La transizione può essere fastidiosa», diceva Isaak Asimov. Non possiamo illuderci: il trapasso è, come canta Roberto Vecchioni, l’unica cosa che dobbiamo fare da soli (Vecchioni R., La viola d’inverno, Il lanciatore di coltelli, 2002 (v.di Antonello Musso, corso aggiornamento Aerf 2017)) ed è ciò che ci spaventa. Ci spaventa l’idea che il futuro sia il non-essere cioè l’assenza dell’identità dell’Io come lo percepiamo in una singola unità di noi stessi. Per difenderci dovremmo iniziare a pensare che la nostra identità sia formata da tanti Io che a livello di coscienza e a livello di inconscio e di esperienza, dialoghino tutti insieme e nel caso si disperdessero dopo la morte manterrebbero comunque una nostra identità sia pure amplificata ed espansa ad un livello superiore. Per far questo però, occorre immaginare che la vita percepita possa non limitarsi a quella indicata dei cinque sensi, ma possa essere reale anche quella vissuta in un sogno. Come esperienza personale, sono riuscito ad applicare l’ipnosi ad un morente di ottant’anni lucido e presente, il quale mi aveva confessato le proprie paure non tanto per la morte in sé ma per la solitudine del trapasso. In tal modo è stato indotto in un sogno guidato da sveglio durante il quale la mia voce lo ha accompagnato in una passeggiata su una spiaggia infinita e deserta verso un orizzonte che si perdeva fra l’azzurro del cielo ed il blu del mare. Durante questo passeggio, la sua attenzione era stata concentrata sulle impronte lasciate nella sabbia (impronte che all’inizio erano quattro e poi sono a rimaste solo due) e lo sguardo spinto in avanti; la mia voce lo rassicurava sulle sue qualità, sul suo coraggio, sul buon esito dei propositi realizzati nella sua vita vissuta. Lo indussi in seguito a chiudere gli occhi progressivamente e a scivolare in un sonno sempre più profondo, immaginando che al fondo di quel percorso, al suo risveglio, si sarebbe sorpreso profondamente e che avrebbe dovuto guardare la nuova realtà con gli occhi e lo spirito di un bambino. In capo a mezz’ora, la persona trapassò serenamente di fronte a tutta la sua stupita famiglia. «Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano. Vivi la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l’unico che sorride e ognuno intorno a te piange». (Aforisma attribuito a Paolo Coelho(
Bibliografia
Alvarez W., Clinico in Chicago.
Berra L., Manuale di Psicoterapia Esistenziale, Libreriauniversitaria.it, 2011.
Brown G., Una vita senza fine?, Raffaello Cortina Ed. 2014.
de Montaigne M., Saggi, vol I.
Duby G., L’arte e la società medievale, ed. CDE su licenza Laterza & figli, 1977.
Foot Moore G., Storia delle religioni, ed. CDE su licenza Laterza, 1989.
Kübler-Ross E., La morte ed il morire, 1969.
La Bibbia, UTET, 1979.
Manicardi L., Memoria del limite, Vita e Pensiero, 2011.
Mistica Ebraica, Einaudi ed. 1995.
Musso A., Lezioni sul trapasso, 2014.
Prior L., The changing face of death, Palmgrave Macmillan, Basinstoke 1997.
Schwarz-Bart A., L’ultimo dei giusti, Feltrinelli, 1976.
Tolstoj L., Morte di Ivan IIi’ič.
Torre M., Esistenza e Progetto, Ed. Medico Scientifiche, 1982.
Vecchioni R. La viola d’inverno, Il lanciatore di coltelli, 2002, (in Antonello Musso corso aggiornamento Aerf 2017).
Yalom I., Psicoterapia Esistenziale, Neri Pozza, 2019.

