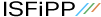
ISFiPP punto di incontro tra
Filosofia, Psicologia e Psichiatria
ISFiPP
Corso Fiume 16,
Torino,
ITALIA,
10133
011 660 6126
segreteria@isfipp.org
Dasein Journal
Rivista di Filosofia e Psicoterapia Esistenziale
OnlineFirst
La dilatazione della morte.
Analisi fenomenologica dell’organo defunzionalizzato
- 2021
- DASEIN 9
«Ogni medico ha una opportunità unica di studiare la natura umana, per cui un filosofo dovrebbe iniziare la sua vita come un medico, mentre un medico dovrebbe finire la sua vita diventando un filosofo».
Kevin Donovan
Abstract
La chirurgia di banco, in ambito trapiantologico, offre la possibilità di analisi fenomenologica circa l’organo prelevato, in uno spazio e in un tempo particolari, prima dell’impianto. La vita e la morte paiono sospesi in un divenire che avrà senso nella ripresa funzionale nel ricevente. La trapiantologia è ciò che concede maggiori spunti di riflessione filosofica e fenomenologica in ambito chirurgico.
Parole chiave
Isidoro di Siviglia (Umberto Curi, Le parole della cura, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017) affermava che la medicina è chiamata seconda filosofia poiché entrambe le discipline sono complementari all’uomo.
In questo senso l’aforisma di Kevin Donovan si inscrive perfettamente nella percezione di una necessità: quella per cui l’atteggiamento filosofico deve accompagnare la pratica medica, nell’interesse della cura, nell’interesse del paziente e, in particolare e in fine, di chi la cura è destinato a prestare quotidianamente. Ma, il primo tempo del pensiero di Donovan, quello cioè che rammenta come ciascun medico goda di una unica e privilegiata opportunità di studiare la condizione umana, è spesso un fatto non sufficientemente valutato.
Il medico è, durante tutta la sua attività, testimone di una vicenda che è densa di sofferenza e di recupero, di vita e di morte, di aspettative e di angoscia. È immerso in ciò che di più intimo i propri assistiti vivono, e ne introita inevitabilmente il peso. L’apertura verso il pensiero e verso domande radicali su tutto, in cui si costituisce la base della filosofia, si rendono necessari per la buona pratica e per la ricerca costante di equilibrio mentale. Filosofia e umanesimo non tesi già alla risoluzione dei peccati della medicina moderna, che vanno dall’eccessiva specializzazione agli interessi economici, dalla depersonalizzante tecnologia all’eccessiva medicalizzazione, ma piuttosto alla possibilità che umanesimo e filosofia possiedono nell’affrontare le questioni di fondo sull’uomo e sull’esserci.
Praticare la chirurgia, in particolare, è occupare una posizione di privilegio e di opportunità uniche per una analisi filosofica dell’esistenza. Dalla propria prospettiva, infatti, il chirurgo ha la possibilità e la grande responsabilità di allargare il suo orizzonte di osservazione, la sua prestazione professionale e il suo aiuto ai malati. Può sospendere, pur avendole costantemente presenti, la teoresi e la tecnica per abbracciare la realtà e derivarne una analisi fenomenologica di ciò che appare, proprio nel momento stesso in cui appare.
Nulla induce di più ad una riflessione filosofica, in medicina e in chirurgia, della trapiantologia. La morte e la vita si lambiscono incessantemente, si fondono, si separano per di nuovo incontrarsi in un turbine di emozioni. Dolore e speranza, morte e rinascita, morte e dono per l’altro, fusione di corpi e funzioni, simulacro di vita e di morte degli organi trasposti nel momento del passaggio dal donatore al ricevente, in una dilatazione spazio-temporale dell’organo defunzionalizzato prima dell’impianto. Ciò costituisce l’atmosfera di vita e di lavoro quotidiani.
Il Centro di trapianto epatico della Città della Salute e della Scienza di Torino ha iniziato la propria attività per l’impegno pionieristico e sotto la guida di Mauro Salizzoni. Nel 2017 ha raggiunto il traguardo di 3000 trapianti di fegato effettuati. Un volume di lavoro che lo pone tra i più importanti centri trapiantologici internazionali, vantando, a fianco della quantità, una elevatissima qualità di risultato, sia in termini di sopravvivenza dei pazienti sia del graft (Il termine “graft”, letteralmente “innesto”, sta nella pratica clinica quotidiana ad indicare l’organo trapiantato. Può essere inteso nel significato di protesi che, innestata nel ricevente attraverso il perfezionamento delle connessioni vascolari e biliari per il fegato o vascolari e ureterali per il rene, andrà di fatto ad essere biointegrata nel corpo del ricevente, diventandone parte strutturale del proprio io organico).
La grande quantità di procedure, sommata al costante impegno tecnico e umano, ha permesso di sviluppare una conoscenza del problema che impegna anche la struttura filosofica dell’atto trapiantologico stesso.
Un particolare e ai più sconosciuto momento della operazione del trapianto è quello che viene definita “chirurgia di banco”. È il momento in cui viene operato l’organo in sé, il fegato in questo caso, isolato e preservato, alcune ore dopo il prelievo avvenuto da cadavere a cuore battente o a cuore fermo. È atto di squisita attività chirurgica, complesso e delicato nel suo divenire, teso alla corretta preparazione del graft dal punto di vista vascolare e biliare. Atto che prepara al successivo tempo dell’innesto nel ricevente. Questi, in contemporanea, viene epatectomizzato, cioè sottoposto all’asportazione totale del fegato malato. I due scenari operatori avvengono nella stessa sala, praticamente nello stesso tempo, con il cosiddetto banco posto dietro il tavolo madre, ove si sta svolgendo il tempo trapiantologico principale. Per questo motivo, con termine inglese, viene definito Back table, dietro appunto al tavolo principale.
Quindi in uno spazio e in un tempo particolari si sviluppano fatti per i quali un’analisi fenomenologica nel momento in cui si manifestano pone la necessità di considerazioni sulla morte, quella del donatore, sulla vita da ripristinare nel ricevente per una rinascita, sul fegato defunzionalizzato che, privato della perfusione del sangue del corpo da cui è stato prelevato e non ancora perfuso da quello del corpo del ricevente, a cui apparterrà, è di fatto sospeso in un simulacro di vita morte, preservato e operato con tecnica chirurgica, che deve rispondere ai dettami di assoluta precisione e efficacia. Appare un’evidenza di dilatazione di ciò che è la naturale percezione della morte, con un organo, una parte di un corpo morto cerebralmente, prelevato a distanza e che rimane preservato, dalla fisica del freddo e dalla chimica dei liquidi dedicati, sino ad aprirsi ad una nuova vita in un ricevente, dopo la perfusione con il sangue di quest’ultimo. La sospensione di ciò che è vita e morte, nel tempo e nello spazio, appare al chirurgo in tutta la sua manifestazione reale. Pone interrogativi filosofici sull’essere umano in tutta la sua complessità. Dalla identità dell’io all’etica, dall’alterità al dono, dalla vita alla morte cerebrale con la rinascita conseguente di un altro soggetto, il ricevente, che beneficia di un passaggio, tecnico ed etico in un contempo, dell’organo donato da altri.
La storia del trapianto è recente. Si è sviluppata nella seconda metà del secolo scorso con Joseph Murray che trapiantò con successo il rene tra gemelli omozigoti nel 1954. Pattern genetici uguali di gemelli omozigoti in quello che si definisce isotrapianto. Nel 1963 Hardy traspose il polmone sino a che, nello stesso anno, Thomas Starlz4 perfezionò il primo trapianto di fegato. A fine carriera egli scrisse un libro di memorie sulla sua vita e la sua professione intitolato Al limite del possibile con sottotitolo Puzzle people. Gli interrogativi filosofici sull’uomo, sul corpo, sull’organismo, sull’intera procedura meritavano e meritano ovviamente un ampio dialogo di senso, di valore, in quel contesto dove rendere umana la chirurgia significa offrire l’esperienza fenomenologica per approfondire i grandi temi filosofici. Nel 1966 Lillehei trapiantò il primo pancreas. Fu solo il 5 dicembre del 1967 che Christian Barnard trapiantò il primo cuore. Solo allora il fenomeno trapianto prese ad essere conosciuto nella sua interezza, con un grandissimo interesse comunicativo-mediatico. Cuore che possiede la potenzialità di un evento ad alto impatto emotivo. Fu solo l’anno dopo infatti, il 1968, che vide la necessità di definire la diagnosi di morte con nuovi criteri.
Marie Francois Xavier Bichat, già nel 1801, nelle proprie Ricerche di anatomia e fisiologia sulla vita e sulla morte, definiva il cuore “ultimum moriens”. Egli poneva, di fatto, il fondamentale concetto che la morte non è un evento, ma un processo. Un processo che coinvolge l’organismo nella sua totalità e che non vede la morte cardiaca come l’evento che decreta il riconoscere la morte dell’essere umano. In stretta linearità con questa visione, nel 1959, due autori francesi, Mollaret e Goulon, descrissero una rivoluzionaria osservazione, dettata dalla tecnologia della ventilazione artificiale introdotta all’inizio degli anni 50 da Bjorn Ibsen. Osservavano, cioè, una situazione definita di coma depassè, qualcosa che andava al di là del coma, in una condizione in cui il “paziente”, ventilato artificialmente, manteneva la funzione cardiaca in assenza di attività cerebrale.
Solo dopo il coinvolgimento generale mondiale che seguiva il primo trapianto di cuore si apriva lo scenario rivoluzionario che condusse al “Ad hoc commitee” di Harvard del 5 agosto 1968. Con la transdisciplinare valutazione di medici, chirurghi, anestesisti, filosofi, etici e teologi vennero poste le basi di riflessione sulla morte cerebrale. Da questo documento che ridefiniva i criteri di accertamento della morte cerebrale, come morte del soggetto, sono derivate le legislazioni internazionali. Furono così possibili i prelievi di organo a scopo trapiantologico dai cadaveri a cuore battente.
Tali criteri di definizione della morte cerebrale hanno con sé una problematica riflessione che va oltre ogni dato biologico, medico o rianimatorio. Pone la domanda filosofica fondamentale di cosa sia l’esistenza, la vita. Avvicinarsi ad un cadavere a cuore battente offre una percezione assolutamente particolare del vissuto della morte, e le condizioni stesse di circolo e di funzione degli organi disvelano un ampio solco spazio-temporale ove indagare la realtà come appare, proprio nel momento che appare. L’approccio intensamente tinto di fenomeni razionali ed emozionali induce un rispetto verso il non sapere, verso l’esigenza di porsi domande sistematiche in una interrogazione radicale su tutto. Operarlo con tecnica tradizionale comporta la consapevolezza di un fine nobile e alto, che è quello del bene rivolto al ricevente, in attesa di vedere salva la vita nella sua interezza e nella sua qualità.
Hans Jonas nella raccolta di saggi dal titolo Dalla fede antica all’uomo tecnologico (1972) riserva una ampia riflessione alla tecnica del trapianto. Nell’intento di invitare, considerato il titolo di morte dato alla morte cerebrale un’usurpazione semantica, a non considerare “un serbatoio di organi” il cadavere a cuore battente. La continua evoluzione delle procedure comporta che il dialogo non possa mai diminuire di tensione e che ogni operatore porti nella propria mente ben presente ogni dinamica intellettuale e fenomenologica, con le valutazioni etiche di responsabilità. Con l’ascolto costante delle voci che pongono dubbi e che invitano al dialogo.
Morte il cui significato fugge nell’assurdo e che si configura in uno degli aspetti dei diversi momenti del trapianto che riguarda proprio e in particolare la chirurgia di banco. L’organo, che è stato precedentemente prelevato vivo, nella stragrande maggioranza dei casi da un cadavere a cuore battente è entrato in un tempo in cui dilata il proprio esserci. È mantenuto in un’atmosfera di freddo e con l’azione di sostanze chimiche preservanti, sino all’innesto e alla nuova vascolarizzazione.
Nel dettaglio tecnico l’intervento di banco è condotto in un tavolo allievo regolarmente allestito e apparecchiato, con tecnica chirurgica tradizionale e occhialini ingranditori. È un momento ricco e denso di una positiva tensione nella manipolazione e dissezione dell’organo prelevato, nel momento in cui è sospesa nel tempo la sua attività, il proprio stesso esserci. È una forma di presenza in condizione di ischemia, cioè a dire priva di circolo, a bassa temperatura. Appare quindi una sorta di dilatazione della morte, in un simulacro che si scioglierà solo quando l’organo, che verrà alla fine trapiantato, sarà riperfuso con il sangue del ricevente e ricomincerà a esercitare la sua funzione. Sempre, ed è nella stragrande maggioranza dei casi, che esso riprenda a vivere e non si verifichi, al contrario, un primario fallimento con morte dello stesso e necessità di un retrapianto. Quindi un organo, una frazione di un corpo in morte cerebrale, prelevato e allontanato nello spazio e mantenuto sospeso nel tempo, verrà a “rinascere” in un altro corpo, integrandosi e diventandone parte fondamentale per la vita stessa del soggetto.
Nell’operare il fegato su banco, l’umanesimo della chirurgia pone quesiti sul manifestarsi di una situazione straordinariamente particolare. L’intervento di banco viene eseguito vicino al tavolo madre dove il chirurgo che conduce il trapianto è impegnato nella prima fase della asportazione del fegato. Si verifica sempre uno scambio verbale tra i due operatori, nel comunicarsi il procedere, eventuali anomalie riscontrate, nella necessità di fare collimare le procedure in funzione della riuscita dell’impianto. La relazione operatoria si allarga. Non più chirurgo paziente, ma triadicamente, chirurghi, paziente e organo.
La tecnica progredisce e la chirurgia di banco si è arricchita della possibilità di condizionare l’organo defunzionalizzato attraverso meccanismi di perfusione ex vivo con soluzioni fredde, per migliorarne lo stato e, oggi, anche con la riperfusione normotermica. Si tratta di ripermeare l’organo con sangue compatibile, portandolo a temperatura corporea, e mettendo in atto meccanismi cellulari che lo portano a migliorare il suo stato di preservazione.
Con tale procedura si osserva una nuova produzione di bile e di fattori di sintesi. L’organo, eso-corporeo, attraverso la tecnica, mostra una vita nella dilatazione della morte che segue al prelievo.
Il tutto viene praticato per consentire una sempre più alta possibilità di buona riuscita dell’innesto.
Alla fenomenologia (F. Varela, Intimate Distances Fragments for a Phenomenology of Organ Tranplantation, Journal of Consciousness Studies, 2001) della morte cerebrale segue quindi una percezione di evoluzione dell’esserci, di un organo prelevato e preservato. Per poi essere isolatamente operato ai fini di una trasposizione in un ricevente dove l’organo stesso, attraversato da un simulacro di vita e di morte durante tale “periodo di mezzo”, lontano nello spazio dal corpo in cui era perfettamente integrato, “rinascerà” in una nuova dimensione esistenziale dopo un certo tempo.
La riflessione filosofica e umanistica della medicina trova terreno dialogico in tutte le sue espressioni e in particolare nella trapiantologia. In questa si compiono i grandi temi di nascita, morte e rinascita (J.L. Nancy, L’intruso, Napoli, Cronopio, 2016). Avvenimenti che consentono di porre quesiti esistenziali e etici profondi e pregnanti sulla natura umana stessa.
Filosofia e umanesimo dell’atto medico teso al riconoscimento dell’esistenza, dell’esserci, dei fenomeni che si percepiscono e che arricchiscono l’intersoggettività, la relazione in generale e la relazione di cura in particolare.
La produzione di bile durante la perfusione normotermica, di una macchina autopoietica vareliana quale appare il fegato defunzionalizzato, riporta alla riflessione schopenhaueriana della volontà della vita, apparentemente irrazionale, di continuare a vivere.
Il fine etico di consentire la rinascita del ricevente offre il senso della procedura, consentita da una tecnica sempre più sofisticata, con scenari futuri aperti a evoluzioni imprevedibili.
Bibliografia
U. Curi, Le parole della cura, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017
T. Starzl, Ai limiti del possibile, Milano, Longanesi, 1993
F. Varela, Intimate Distances Fragments for a Phenomenology of Organ Tranplantation, Journal of Consciousness Studies, 2001
J.L. Nancy, Corpus, Napoli, Cronopio, 2014
ID., L’intruso, Napoli, Cronopio, 2016
